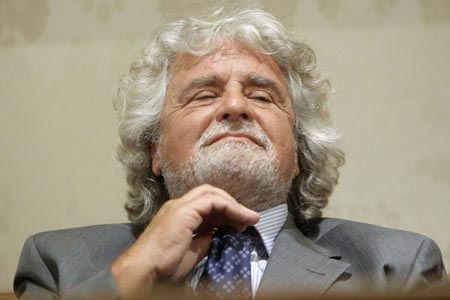di Vanni Sgaravatti
Tutte e tre le dimensioni permettono un equilibrio tra la sfera economica e quella politica e migliorano le opzioni di libertà per la maggior parte delle persone. Nell’integrazione di quelle tre dimensioni, il potere politico dovrebbe essere regolato dalla democrazia, intervenendo per far sì che il mercato sia libero davvero.
L’intervento, però, non si dovrebbe limitare agli ammortizzatori sociali per contenere l’impatto sociale delle esternalità negative, tipico del pensiero economico progressista degli ultimi anni, accodato, in parte, ai dettami neoliberisti. Né, come succede in Europa, dovrebbe limitarsi a verificare passivamente che non ci siano concentrazioni di potere economico (antitrust). Dovrebbe presiedere i fattori extraeconomici che impediscono il libero mercato, cioè tutte le asimmetrie, derivanti da disuguaglianze economiche e sociali e promuovere innovazioni in ambiti produttivo di beni e servizi, con capacità di spillover, di minimizzazione delle esternalità negative e massimizzazione di quelle positive.
Ma è la democrazia che permette l’orientamento degli interventi, così da massimizzare la partecipazione alla vita sociale delle persone, internalizzando realmente le preferenze delle stesse. E la democrazia assicura questo risultato, operando attraverso poteri compensativi di auto bilanciamento fondati sulla indipendenza dei poteri tra chi pianifica, gestisce, verifica, corregge e rivede le stesse norme, e, questo, a livello macro-istituzionale, significa indipendenza tra il potere esecutivo, legislativo, giudiziario.
È in queste condizioni che il libero mercato può diventare un’altra forma per esercitare la libertà del singolo di intraprendere iniziative e diventare una tra le fonti principali di determinazione e comunicazione dei desiderata e delle preferenze delle persone.
In Cina e in Russia, la storia è profondamente ancorata ad una assoluta prevalenza della sfera pubblica verso quella economica, che, senza i contropoteri democratici, diviene portatrice di autarchie e oligarchie. L’inefficienza e l’inefficacia di governance hanno portato nel tempo a pianificare l’ampliamento artificiale degli ambiti di mercato, diventando un capitalismo di Stato.
Tale capitalismo non solo è limitato ad ambiti in cui lo Stato non è interessato ad intervenire, così come, del resto, succede anche con una governance democratica-sociale, ma è indirizzato ad orientare il mercato verso la società progettata in base ai desideri di pochi. Così facendo il capitalismo di stato, perde, ovviamente, la funzione informativa che permette di massimizzare il bene per i singoli, oltre a costituire, nel lungo periodo, un limite depressivo alla iniziativa imprenditoriale, che limita l’innovazione e quindi la stessa efficacia del sistema, anche negli ambiti lasciati al “mercato”.
È anche vero che, come diceva Keynes, “nel lungo periodo, siamo tutti morti”, mentre, nel medio periodo, il maggiore ordine che ne deriva potrebbe aumentare la competitività internazionale del sistema. Ma, questo fattore potrebbe diventare un elemento per irrigidire il percorso, tale da impedire il passaggio ad una successiva fase di maggiore libertà imprenditoriale, magari contrariamente alle stesse intenzioni programmatiche futuristiche dei leader autarchici.
In America, il neoliberismo ha assunto forme più estreme che in Europa: per combattere le concentrazioni di potere occorrono prove schiaccianti (limiti all’antitrust); è diffuso l’obbligo contrattuale al ricorso arbitrati nei contenziosi imprese lavoratori bypassando la magistratura; sono minimizzati gli interventi statali in termini di ammortizzatori; si spinge verso una deregolamentazione e le correzioni alle esternalità negative, come quelle ambientali, sono molto più limitate (il possesso privato del sottosuolo e relativo sfruttamento delle risorse); sono limitati gli investimenti nella scuola pubblica, per non parlare della sanità, senza obblighi alle assicurazioni sociali; sono pianificate forme elettorali che premiano le élite e il sistema lobbystico e di finanziamento pubblico è molto più esteso che in Europa.
La giustificazione morale a tale sistema poggia, tra l’altro, sulla narrazione relativa alla contrapposizione tra la libertà dell’iniziativa privata e lo statalismo e che non corrisponde alla realtà. Da una parte, quando il sistema americano era più democratico sociale lo Stato è intervenuto come committente principale per la Silicon Valley, dai microchip, alle comunicazioni digitali, ecc., dall’altra quando cercava di seguire le idee di Friedman della scuola di Chicago sulla minimizzazione dell’intervento statale, in realtà è intervenuto imponendo, con la forza dello Stato, per imporre regole nazionali e internazionali a protezione dei diritti di contratti.
Contratti, però, stipulati in base alla logica del più forte, come quella che avviene tra datori di lavoro e lavoratori sempre meno sindacalizzati e quella derivante dalla regolazione monetaria, che aumenta i tassi di interesse che incidono sui debiti dei paesi poveri, per ragioni di contenimento di politiche monetarie, di cui quei paesi non hanno alcuna responsabilità.
Di fronte al fallimento della ricetta neoliberista, in termini di aumento delle disuguaglianze e dell’impatto ambientale e della stessa efficacia in termini di innovazione, i neoliberisti hanno detto che ci sarebbe voluto ancora più libertà in mercati deregolamentati, proprio quando l’innovazione ha fatto emergere il business delle piattaforme social. Un modello di business unico che ha permesso le concentrazioni monopolistiche che hanno invaso tutte le sfere della vita sociale e, quindi, di fatto hanno reso il mercato molto illiberale, in modo quasi irreversibile.
La fusione tra la sfera della politica e dell’economia in America è avvenuta di conseguenza, spinta, ovviamente, come sempre, dagli interessi, di chi è stato più rapido a diventare un lupo. A questo punto, il sistema americano è diventato di fatto un capitalismo di stato, cioè un governo le cui preferenze sono stabilite al centro, in quanto eccezionalmente plasmabili, dai pochi che detengono il potere. La burocrazia, a questo punto, è diventata uno strumento di attuazione del potere e gli algoritmi effettuano questo ruolo in modo efficace, e non costituiscono certo un insieme di regole che preservano l’equilibrio dei poteri, come nelle immaginate democrazie sociali.
L’unione tra le autarchie: russa, cinese e americana non è quindi solo il frutto di un disegno egemonico di potenza, studiato in una logica militare, ma diventa, il frutto di una condivisione di visione. Anche se, tra lupi, cioè tra soggetti che vedono il potere legittimo basato sull’identità di Stato, alias sovranisti, si innescherà un processo iper-competitivo dalle conseguenze imprevedibili.
Ci sono delle crepe in questa visione diagnostica e le troviamo anche negli USA: nella libertà ancora esistente nei luoghi di formazione di eccellenza (Harvard) e, soprattutto; nella magistratura di medio livello e nella cultura europea e britannica che hanno esperienze di cosa significa la competizione tra sovranismi, con conseguente frammentazione e conflittualità sociale.
Le potremmo ritrovare, le crepe, nella stessa delusione dei consumatori di telefonini o simili, quando la confusionaria concorrenza economica sovranista non assicura il benessere materiale promesso, e la possiamo ritrovare, a mio parere, nella lotta per la libertà del popolo ucraino, al di là di calcoli, vantaggi, compravendita di diritti, che meglio rappresenta le esigenze di sicurezza dell’Europa del Nord, dai paesi baltici a quelli scandinavi.
Ma la divisione tra nazioni europee e la divisione, ben studiata dalla propaganda, tra poveri dei paesi ricchi e poveri di quelli poveri, non lasciano ben sperare sul fatto che quelle crepe si allarghino fino a diventare un terremoto in grado di far cambiare rotta verso il modello che, personalmente, ritengo costituisca un progresso: quello democratico, sociale, di libero mercato. Quando, per libero mercato, intendo un luogo dove esiste la libera iniziativa imprenditoriale, una libertà che finora non si è mai vista nel capitalismo reale, dove ogni imprenditore aspira a vendere il prodotto migliore, che diventi l’unico prodotto acquistato da tutti i consumatori del mondo e, quindi, tende al monopolio.
Molti si convincono, in questo contesto reale, che le regole servono proprio per fare in modo che le partite siano aperte, a dispetto della volontà dei singoli potenziali monopolisti.
Ed è alla luce di questa metafora, che, di fronte al fallimento dei mercati, qualcuno narra che l’arbitro si è messo a parteggiare, che ha creato troppe regole, ma pochi operatori economici si concentrano sui valori di chi ha premuto perché l’arbitro parteggiasse, come se il parteggiamento o meglio la collusione, fosse una delle variabili di mercato come un’altra, utile a prevalere sui concorrenti.
Allora, pare più facile pensare che senza arbitro da corrompere, senza arbitro (lo Stato) che interviene tutto filerebbe liscio. Ma, per chi filerebbe liscio? Nel lungo periodo, quando saremo tutti morti, per nessuno; nel breve e medio periodo per gli oligarchi e per chi prende le briciole più grosse che cadono dalla tavola imbandita.
(22 aprile 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata
Iscrivetevi alla nostra newsletter (saremo molto rispettosi, non più di due invii al mese)